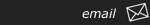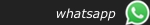Le stagioni
Erano quattro fino a qualche decennio fa. Erano state celebrate da tutte le Muse: si dirà, sfoghi di gente che amava trastullarsi con i fenomeni della natura. Ma quando una volta “Barbanera” e “Frate Indovino” scrivevano (e scrivono giacché si ostinano a sperare che le stagioni non diventino completamente pazze) prevalentemente di Botanica, non facevano altro che esprimere cognizioni tecniche applicate alla coltura dei campi secondo l’avvicendarsi regolare delle fasi dell’anno: perciò quelle informazioni erano precise e preziose perché venivano elaborate sulla base di previsioni che puntualmente si realizzavano nel succedersi dei mesi. Perché fino a poco tempo fa il calendario era un registratore fedele; ora che non lo è più anche “Barbanera” e “Frate Indovino” entrano nel novero degli artisti.
Le stagioni erano quattro anche a Cocullo. La lunga sinfonia dell’anno si apriva col rigoglio lussureggiante della primavera, continuava con l’adagio maestoso dell’estate e poi con i colori e i frutti autunnali per concludere il ciclo nel riposo dell’inverno. Adesso i tempi di quella musica sono sconvolti perché le stagioni non vivono più in armonia, perché si fanno guerra e quelle più prepotenti invadono troppo frequentemente il territorio di quelle timide e schive. Che in genere sono la primavera e l’autunno; ma pure l’inverno e l’estate hanno perso il loro fascino, anche se pretendono sempre gli onori della ribalta; ma con una riserva, perché ormai alla seconda è concesso solamente un piccolo spazio riempito di calura asfissiante, quindi pare che abbia vinto l’inverno a dispetto del forte e repentino riscaldamento del pianeta. Ricordiamo le stagioni come le vivemmo.
Le propaggini dell’inverno proiettavano nell’anno nuovo la suggestione della Befana, la vecchia tanto cara ai bambini per la sacchetta di doni da cui estraeva e deponeva sul piano del focolare (o infilava nella calza legata alla catena che solitamente sosteneva il paiolo), pochi regali che facevano la gioia dei destinatari: per i più poveri erano fichi secchi, qualche noce, qualche mandarino, magari qualche quaderno (che a quel tempo era ancora gradito anche ai pastorelli che talora facevano i compiti mentre pascolavano) e, ma solo alle femminucce, una “pupella” di pezza. Per le bimbe fortunate le bambole erano di porcellana, imbellettate ed abbigliate secondo la moda dei signori; ma, da quando si sono intromessi con la loro slitta i cornuti animali del concorrente nordico (un certo Claus), le posizioni si sono capovolte: adesso sono i ragazzetti che aspettano le “pupelle” con le trine della sottana rosa, specialmente quelle “immortalate” nelle pellicole cinematografiche o riflesse nei cristalli liquidi. Forse in molte case ancora si allietano i bambini con l’ausilio della vecchietta, oggi più provvida di doni, nella cappa del grosso camino; almeno dove questo non è stato sostituito dal più moderno, piccolo e decorativo, caminetto o addirittura dagli elementi dell’invadente termosifone. In altre, purtroppo, la gradita visita della vecchina è stata sostituita con cerimonie e costumi esotici spesso improntati ad un crudo realismo che induce i fanciulli a non credere più (o a far finta di credere) alle favole.
Come stanno cambiando le abitudini! Povera Befana! E’ un po’ dura a morire, ma è troppo stagionata, non cavalca più la leggendaria scopa. Si è seduta stanca e con il bagaglio di ricordi nostalgici davanti al camino da cui pende il mozzicone arrugginito dell’ormai inutile catena.
Il tramonto della stagione fredda era annunciato dalla violetta sul prato. Dopo poche settimane sarebbero tornate le rondini garrule a frotte e più tardi il cuculo avrebbe accompagnato con un ritmo monotono il brontolio del rivo ingrossato dalle nevi che si erano sciolte in montagna (forse molti bambini non sanno che sul suo letto ormai secco correva un torrente impetuoso, il quale fino ad un paio di secoli fa aveva alimentato il mulino della “Réfota” del Casale, e che ai primordi si chiamò Flaturno). La valle si ripopolava: sembrava che si fosse tornati ai tempi del calendario romano il quale assegnava a marzo l’inizio dell’anno.
Arrivata la stagione calda, alla fatica della mietitura si alternavano il fastidio dell’afa e poi la frescura della notte. Allora la vita scorreva con l’operosità dei pastori allo stazzo e poi, di giorno, con quella dei contadini impegnati nel girotondo della “tresca” o nell’assordante moto della macchina trebbiatrice mentre il canto del cuculo diveniva sempre più assillante. La notte era ravvivata anche, a tarda sera, dai giochi dei ragazzi, che nel tempo propizio si estrinsecava con le serenate.
Un proverbio recitava: “Con la prima acqua di agosto il povero dal ricco si riconosce”. E già, perché i vestiti leggeri erano alla portata di tutte le scarselle, ma quando sopraggiungevano i primi freddi soltanto le persone un pochino facoltose erano in grado di conciliare l’eleganza con capi d’abbigliamento adeguati alla stagione. Le piogge, ancora per poco calde, divenivano sempre più insistenti e fredde. Però la coda degli ultimi temporali estivi aveva concesso qualche tregua, tra una folata di vento e l’altra, ai seminatori. Intanto cominciavano a staccarsi dai rami le foglie, che avevano esaltato l’autunno con i colori più belli dell’anno; al lussureggiare della natura partecipavano adesso anche le tinte e …il gusto dei grappoli d’uva. E il pentagramma autunnale si arricchiva con la tavolozza della vendemmia. Poi le cantine si animavano per via della pigiatura, al caratteristico rumore dei torchi si associava fuori, tanto per rendere più pittoresche le vie del paese, il profumo del mosto cotto in grossi paioli: prezioso ingrediente necessario per fare il succulento sanguinaccio e che ancora oggi serve agli Scannesi nella confezione degli squisiti mostaccioli. Lassù, alla svolta, le urla disperate di un maiale sacrificato alla culinaria avevano annunciato la prima nevicata e la novena di Natale preceduta dal suono della campana.
La neve era ormai alta e al centro della strada era stata scavata la “viarèlla” che imbottigliava il traffico dei pedoni intabarrati, mentre non riusciva ad ostacolare la corrente del rivo che tumultuava fra i macigni coperti da un soffice strato bianco. Questo era spesso sui campi arati di fresco, e ci si divertiva ad emulare gli sciatori con rudimentali aggeggi più simili a tavolette che agli sci. Certo, per i ragazzini l’inverno era una festa celebrata con le palle di neve o con le sculture dei pupazzi rilucenti al timido sole invernale. E, quando il Natale si approssimava, le tavolate di polenta farcita di fagioli e salsicce e spuntature di maiale precedevano il posto alle cartelle della tombola. L’anno nuovo, pure lui, si accingeva a coprirsi con il mantello bianco. La sua immagine diveniva sempre più invadente sull’ultima pagina del calendario, mentre lo stanco vecchietto si dileguava fra gli stessi brindisi che lo avevano acclamato dodici mesi prima. Sic transit gloria mundi: è una formula solenne che vale anche per il giovincello entrante, che così, sempre, arriva e se ne va. Sempre.
Questo brano l’ho copiato da un mio scritto, inedito, giovanile, quando il signor brontolone metteva a confronto il mondo attuale con quello della sua adolescenza. E’ vero che la cantilena “ai miei tempi…” è risuonata dai millenni, quando gli scatti del contachilometri della vita, cioè i compleanni, segnavano dei mutamenti, a volte fratture, tra le generazioni; ma in genere quei salti generazionali producevano nei vecchi non soltanto ricordi nostalgici, poiché essi si articolavano armonicamente. Però forse l’avvento del cambiamento climatico ha causato un salto abissale: fu da quando cambiarono mode e usanze, prodotte dallo sviluppo sociale che in questi ultimi tempi è stato vertiginoso, grazie all’incontro più intenso fra popolazioni diverse. Certo, questo è un fatto positivo, con tutte le riserve, per esempio negli scambi commerciali, nelle fusioni tra civiltà, ecc.
Il fenomeno si è accentuato con il degrado della musica, con l’aggressione al vocabolario e alla grammatica, con il decadere del senso civico (uso di acronimi, di barbarismi, abuso di termini spregevoli e volgari…).
Oggi si parla troppo spesso dell’ “intelligenza artificiale” (“artificiale” è un aggettivo derivato da “artificio”, il quale può significare anche “espediente trovato con arte per raggiungere un migliore effetto, per creare un’illusione, per far apparire più bella una cosa” (v. Treccani). Il significato preciso di questo stratagemma lo conoscono gli ingegneri e il loro codazzo di cervelli. Per il semplice uomo di buonsenso sembra che sia pericoloso il ricorso alla tastiera elettronica invece che alla intelligenza umana: si pensi che, a parte i possibili errori causati dall’aver pigiato un tasto anziché un altro, si pensi che i tecnici possano interpretare a volte l’uso corretto in modo diverso, ecc. Questo non vuol dire che in alcuni casi si possa trovare il modo di condividere l’uso della tecnica; ma… abbiamo l’esperienza della carne coltivata…
Allora restano l’aurora che compare sulle stagioni e lo zero che corrisponde all’omega del lessico greco: vita e morte! Preferirei che lo spiraglio di luce di una “novella” aurora prevalesse sullo zero.